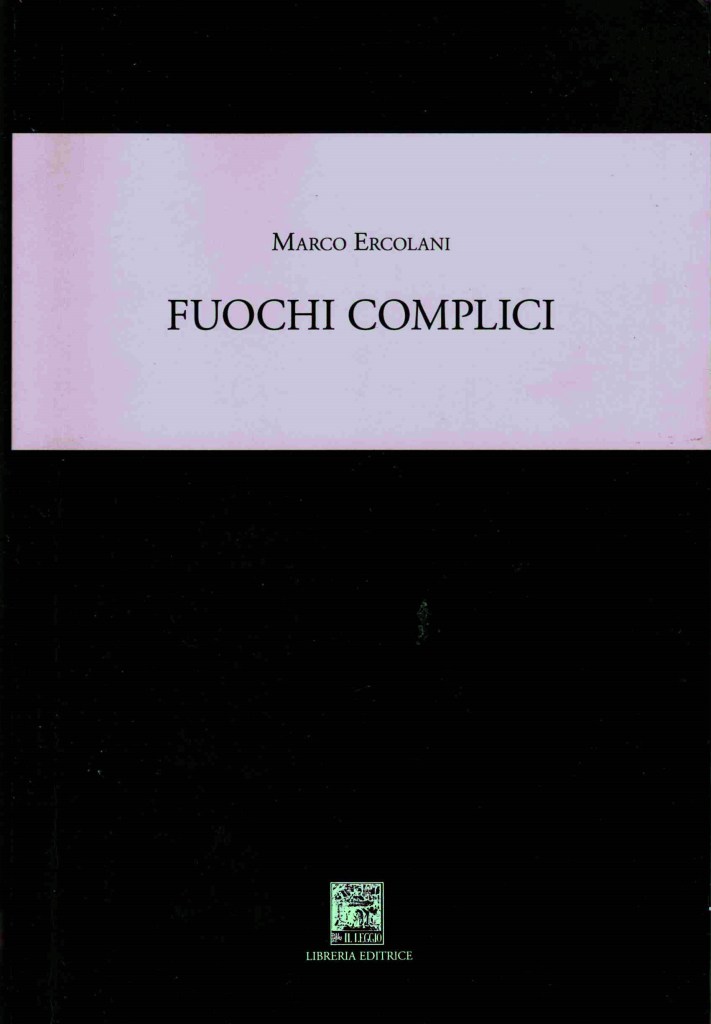**
Ho fatto un grande sogno ma non ne ricordo
niente babbo amiamo le teste bruciate
dell’amore ma non la misericordia e
i chiodi come coltelli di gelosia
tra poco cadrà la strada su di te
spergiuro sulla mia infanzia scrivo
lettere, se non mi dai da mangiare
i capelli mi diventeranno come crine
e come un fucile. Notte di lupi
sprangare l’angelo del vento
qui è la piega
dove non sarà nuovo morire
Scrive Gilles Deleuze: «Il mondo è l’insieme dei sintomi di una malattia che coincide con l’uomo. La letteratura appare allora come un’impresa di salute: non che lo scrittore abbia necessariamente una salute vigorosa ma gode di un’irresistibile salute precaria che deriva dall’aver visto e sentito cose troppo grandi, troppo forti per lui, irrespirabili, il cui passaggio lo sfinisce ma gli apre dei divenire che una buona salute dominante renderebbe impossibili. Da quel che ha visto e sentito, lo scrittore torna con gli occhi rossi, i timpani perforati».
Quelli che si attardano sul fondo dell’abisso; che tornano, sventurati, gli occhi iniettati di sangue, senza ancora la forza di parlare: che la loro vertigine si decanti nel cercare le parole. Ascoltiamoli, dopo quel lungo intervallo. Non sembrano forti ma lo sono. Messaggeri, certo. Cos’è, il mondo altro, senza messaggeri che ne riferiscano? Occorre rischiare per essere uomini che vedono e non si sottraggono. I colloqui fra folle e sano restano sempre una serra artificiale che a stento contiene l’inferno. Anzi, l’inferno non entra mai veramente in quelle parole, che costruiscono un ordine già voluto, una reciproca complicità. L’inferno è altrove, dove domina un silenzio privato del senso.
Verso la mente di Nadia Campana, nata a Cesena nel 1954 e morta a Milano nel 1985 (cura di Milo De Angelis, Emi Rabbuffetti e Giovanni Tesio, Raffaelli 2014) è una raccolta poetica imperfetta e inafferrabile che vuole combattere quel silenzio insensato; monologo lirico di un io femminile inquieto, ombroso, visionario, che segue un ritmo sincopato, fluido e affannato insieme, dove lampeggiano paesaggi ansiosi («punta tenera di un dardo / ora io esisto ancora / sfinita dal correre è vero, / mi porti sulle ossa / finché la notte non mi contrari più / madre ogni minima cosa») e immagini di catastrofe dove i confini del corpo e del mondo sono labili («Non è una caduta priva di luce / non è dei capelli tirati / da mani che vogliono ordine: / dal bordo della finestra spio / la tua maschera e il gas / che ora sentiamo per gioco / siamo in alto in cima alle mie trecce / laggiù c’è il mare laggiù»). Nadia Campana, sulla scia di Silvia Plath, si toglie la vita per inseguire una bellezza straziata e impossibile, con improvvisi slanci verso la quiete («odore di / erbe / io vengo a farmi in te vuoto fedele / a un tratto nel regno / le cose sono brezza / leggere senza pensiero»): è una poesia, la sua, scritta dall’interno di sé, con accessi e convulsioni, una poesia che va “verso la mente” come verso un approdo sicuro che ripari dall’angoscia da cui il corpo è percorso. Nadia vuole essere interrotta, slacciata, “de-mente”. Cerca una via di fuga. Nadia suggerisce l’idea di una poesia che va in “febbre d’amore”, e da contratta e inquieta diventa dolce e quasi consolante, oscilla dal desiderio di calma all’allegria irrequieta: una poesia scorticata, che matura dentro se stessa, che arriva fino alle soglie dell’autocancellazione («come ti chiamavo/ a cancellarmi»), restando sempre nascosta, come un io segreto che monologa con un altro io segreto. Ma è poesia spesso amorosa, anche se di un amore dove l’io e il tu fanno fatica a distinguersi; amorosa ma introflessa, non mistica ma sigillata dentro il proprio sé, vissuta all’ombra di poeti complessi come Porta e De Angelis, di cui forse Nadia ha amato e vissuto la parte più visionaria e urticante. Una poesia, la sua, ustionata dalla sua stessa innocenza. Una poesia senza riparo, astratta e dolcissima, che non riesce a fare da schermo a un io esposto, vulnerabile, non drammatico ma angosciosamente lirico.
Il potere della metafora, più che nelle articolazioni della figura retorica, vive nella funzione ricreatrice della realtà, nello sviluppo degli echi e delle analogie, delle ‘vie svianti’ della parola. L’uomo vive volendo essere altro da sé e superando i propri confini, proprio per comprendere se stesso. In «Circonferenza di Marina Cvetaeva», testo di una conferenza del 1982, ora raccolto dagli stessi curatori di questo libro in Visione Postuma (Raffaelli, 2014), Nadia precisa il senso della sua poesia come pratica ascetica e amorosa allo stesso tempo. Ricorda che in Cvetaeva «non esiste […] frattura tra amore e poesia perché nascono dallo stesso enigma» e che solo grazie ad un’autoesclusione dalla vita comune si può scrivere «dall’amore e nell’amore abbracciando senza mediazioni l’altro dall’inizio alla fine», svincolando la parola poetica dai lacci del pensiero e dal credo politico. L’unica maniera in cui una cosa può anche esserne un’altra è “l’essere-come” o il “quasi-essere” della metafora poetica. «La vetta/ si dissolve in turbinii,/ con più furia ancora/ che voi» (Paul Celan). Il poeta sa che il mondo non è più lo stesso dopo che lui ha pronunciato le sue parole. La scrittura, ancora una volta, ripulisce lo sguardo dallee incrostazioni di vecchi sensi. Gli artisti veri devìano e deformano, aiutano a ri-vedere e a ri-sentire, indicano soglie nuove dentro percorsi antichi. «Si sta/ come d’autunno/ sugli alberi/ le foglie» (Giuseppe Ungaretti). Si può, dopo questa poesia, rileggere Mimnermo e gli altri poeti della classicità, senza avere nelle orecchie la voce chiara e perentoria del poeta di Allegria? La voce ulteriore di Nadia Campana obbliga a rileggere i poeti che l’hanno preceduta, apre un diverso ordine alle cose, produce una nuova metafora che si rifiuta di evocare i codici previsti ma vuole rinominarli – enunciarsi con coraggio, irripetibile:
come mondi sognati da miriadi di sogni
sradicati al centro quasi affondando
diciamo.
Solo così, in questa luce di apocalisse, Nadia può, “quasi affondando”, dire di sé («e coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da coloro che non potevano sentire la musica», Friedrich Nietzsche).
*Il testo è tratto da: Marco Ercolani, Fuochi complici, Il Leggio Editore, Mestrino 2019.
Nadia Campana nasce a Cesena l’11 ottobre 1954. Si laurea a Bologna su Antonio Porta, il relatore è Luciano Anceschi. A Milano frequenta la vita letteraria e pubblica alcune poesie. Circa cinquanta poesie verranno pubblicate dopo la sua morte, nel 1990, con il titolo Verso la mente. Nadia si suicida, a trent’anni, il 6 giugno 1985, gettandosi dal ponte di via Corelli a Milano.
**
Testi
Che mi lasci guidare prematura
farmi portare impadronita
non reggono al confronto delle braccia
valigie piene di esempi
folate indicano il cappello soltanto
mutandosi in fili spazzati
e semi non custoditi in direzione
barca abbandonata lungo il fiume
guardo il ponte, un vero confine,
strappo le tasche e dal biglietto la sua fede:
si scioglie sulla guancia
la gioia del declassato.
Avendo già avuto a che fare
con la resa, scelgo
le processioni del riposo.
Io e la luna sorgente
in un punto remoto assonnate come cani
compressa da fatiche piagata
spostando di qualche strada i passi, spiccano
una dopo l’altra tenaci uguaglianze di tempo.
*
come un folle mago mi estraggo
dal petto la sete
bianco, giallo, stracci di ogni colore
spira il vento che assomiglia a pietra
sporge la gamba
accenna un passo di danza
s’incrina il bacino
si perde l’equilibrio
sul volto scende la saliva
*
perché cresca la luce
perché cresca il buio
perché al chiuso – questo –
crollano umani
rivestono di pori le gocce
d’oscuro chiama la schiuma
accesa tondo rovescia
oscuro più oscuro
annaspandoti, e tu mia mente
*
Noi, la lunga pianura immaginaria
ci inghiotte come sacramenti della notte
Sei stato una quantità esatta
nella pioggia che afferra i visi
ma adesso in ogni angolo della stanza
aspetteremo fuori dall’esplosione
un legno che io, qui,
ho costruito (lasciami fare)
prodigi scelti dal caso, pioppeti da percorrere!
Il tenero è nel mezzo e nell’interno
umiltà di una porta
ascoltando treni, a un passo, come
una febbre nel ricordo esattamente.
Guarda il campo
è così calmo, smisurato, stamattina.
*
Guardiamo dalla cima del monte
il filo di calma che è nato
del mio petto tu conti ogni grano
e ogni cuore si prende di colpo
il suo tempo: un amore
è tornato e si è accorto
il suo disco ci copre.
Adesso tu devi guardarmi
per quella collana di sì
nella mia pelle che apre
la piana la strada
e i fondi della notte
i centesimi della sete.
*
gli uccelli strappano il deserto
per vedere se stessi
scrivono nel cielo
– noi aspettiamo come mali idioti
che avanzano piano
le grida suonano
caricandosi nel cervello
fa giorno, come il cielo tutto rosso
*
il ruscello ha
molta fretta e trascina
la sua famiglia senza fine
la metà del tempo pensavo a me
quando ero bambino pensavo da bambino
ero nella nave inondata
ho visto fare l’acrobata
ero un re
molto triste e buono nella mia stanza
arriva un nano i morti non si contavano
ero in un campo verde
dove passeggiava una donna bella
un uccello arrivò e le rapi la collana
mi trovavo in un posto
c’era una ruota e si saliva
ognuna di noi teneva un’amica sospesa
in aria poi in molti appesi e stanchi
ci si lasciava cadere piangevo
perché mi era scivolata direttore
chiudete ma lui non ascoltava
il ruscello ha
molta fretta e trascina
la sua famiglia senza fine
*
Ho dovuto riconoscere, come per la Dickinson, che i tempi della distanza con le mie diffuse sensazioni di morte fossero gli unici possibili, pena la mancanza di riconoscimento della trascendenza mia e dell’amato. Anche se sentivo che era così assurdamente superfluo ferirsi per saziare gli dèi della paura, del futuro, della coazione a ripetere, mi era impossibile attraverso la poesia dire il mondo come è e non come dovrebbe essere. Potevo solo dire, con un po’ di disperazione, che fare le parole era un’imperfezione del cuore e che restavano le mie uniche deboli armi.
Finisco con i miei tre versi:
Mi porti sulle ossa
Finché la notte non mi contrari più
Madre di ogni minima cosa.