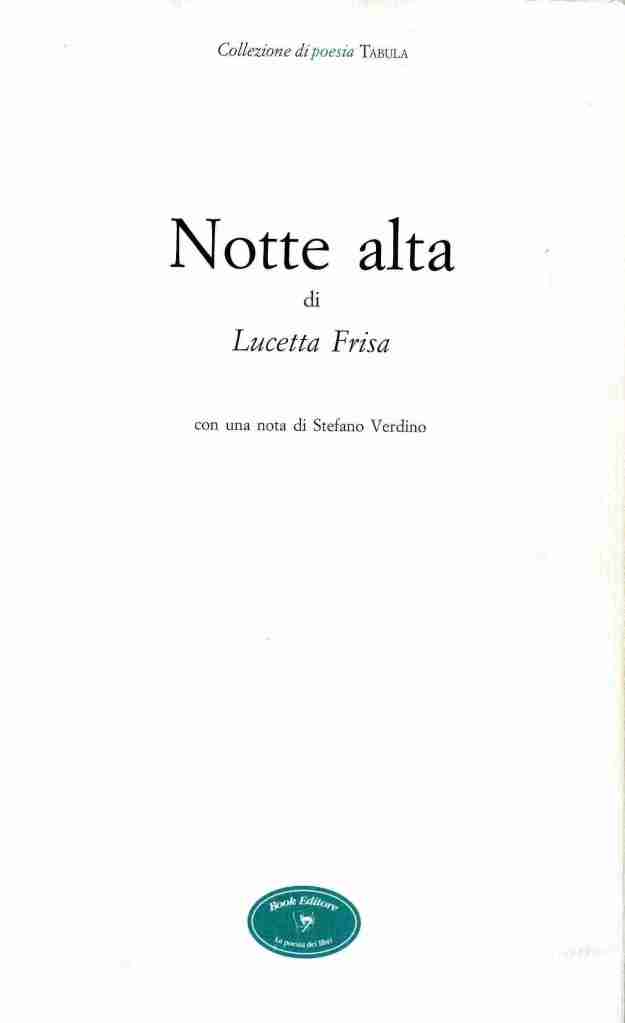
La scrittura di “Notte alta”, breve prosa poetica contenuta nell’eponima silloge del 1997 (Lucetta Frisa, Notte alta, Book editore, 1997), si svolge all’interno di un processo di rinascita, che prende le mosse da un’esperienza di premorte, di cui cerca di invertire il senso. In questo contesto, il problema centrale, dichiarato già nel primo degli otto mo(vi)menti in cui si articola il testo, è quello del perdere e prendere forma, della scelta fra forme diverse (“Cosa nasconde quel luogo? Non so se ha forma di rettangolo o di cerchio”), in cui in fondo consiste l’atto stesso del nascere (e del rinascere). Il boccascena, infine, è quello onirico di una spiaggia al tramonto – ricorrente fin dai sogni di bambina dell’autrice – dove il sole compare su un orizzonte vuoto: “sabbia tra gli alluci e io che mi dico affrettati a riempire gli occhi di tutta questa meravigliosa luce”.
Per meglio comprendere queste prime sintetiche annotazioni, può essere utile rilevare almeno che, all’interno dell’intera silloge, Notte alta si trova in un punto di contatto fra terminali in cui il dato autobiografico e onirico si va intensificando lasciando gradualmente il posto alla prosa (“A fine verso si spalanca lo spazio del respiro prima di rovinare indietro. Si può morire di asfissia o anossia. Per gravità di suono? Dipendenza da un ritmo?” – versi centrali in “Verso Palermo”), e il patto fra “poesia e morte” viene formalmente dichiarato, come rileva Stefano Verdino nella postfazione al libro (“La poesia non copre la morte/la scopre piano piano finché non puoi parlare che di loro/della poesia e di lei – loro due insieme e null’altro” – versi centrali invece in “L’arte di non pensarla”).
Che Notte alta si collochi all’interno di un’esperienza di premorte è esplicito: “al corpo, per morire, occorre molto più tempo; la mente giunge al traguardo per prima e si mette in attesa. Giorno per giorno lo aspetta”; oppure “Scrivo perché scrivendo posso simulare mille e una volta questo attimo che precede la morte”. E che, al suo interno, si tratti di un processo di rinascita, è dato nei molti riferimenti che innervano la prosa in un tentativo costante di riemersione: “La fessura del soffitto che si affaccia sul cielo aperto, e ricorda la debole fontanella dei neonati, mi porta l’immagine dell’infinito”; “Nella città labirintica (…) l’abitante si occulta in posizione fetale”; e prima ancora: “Un bambino prende in mano foglio e matita e traccia, al centro, a caso, uno scarabocchio: è il segno di un groviglio. Lì sul foglio, come sulla superficie terrestre, sembra piatto. Ma basta alzare lo sguardo, e la profondità emerge”. Rinascita come riemersione quindi, che inverte il senso della premorte sostituendo al tramonto del sogno l’alba di un sole sorgente (“Sempre il tramonto, mai l’alba”), di cui Notte alta è anche metaforicamente tramite nel suo porsi esattamente a metà – Venere occulta – nello spazio palindromo che separa l’ultimo raggio della sera e il primo del mattino.
Il processo di rinascita si compie dunque nella scrittura, intesa nella sua capacità di porsi come “punto di equilibrio” fra forme, a iniziare da quella elementare, ma geroglifica, etimologicamente intesa e quindi sacra in radice, di un bambino, perché “Imparare l’alfabeto è un rito che libera forze per poi trattenerle, snodarle e annodarle, almeno per l’attimo della frase”. Si tratta di un percorso, quasi <reiniziatico>, in cui il comporsi dell’equilibrio che fonda la rinascita è interpretazione di quello scarabocchio che, come detto, si può comprendere solo alzando lo sguardo, in un’acquisizione elementare e sorprendente che lo ri-vela “sulla chiocciola, sulla conchiglia, in certi insetti, nel disegno della tela del ragno, nelle orbite planetarie”: nell’infinitesimale e nell’infinitamente grande. Ma anche nel corpo, ad esempio nelle forme annodanti di un <ombelico-omphalos>, che “dopo la nascita, si richiude come un sigillo”, o in quelle dell’orecchio che “ci unisce alle vibrazioni dell’universo” e infine nelle forme del cervello, che “comprende tutte le memorie” e richiama nella forma lo <stilema> delle città in cui viviamo, che fin dall’antichità “viste dall’alto (…) assomigliano a tele di ragno”. Si tratta, a ben guardare, di forme vorticanti ellittiche sinusoidali, mai pure, mai chiuse, sintesi di forme, di tensioni, di diverse energie (“Divino è l’inizio di un vortice che semina suoni”), in cui la scrittura, ma sarebbe meglio dire: la ri scrittura di Notte alta sviluppa con i suoi segni la difficile relazione fra punto e linea in cui si in-scrive la realtà (punto come “centro” o “neo bizzarro”, linea come orizzonte o “linea curva” sulla cui cima “si vede il possibile”), risolvendo in immagini e in un <surplus di senso> le forme sempre in tensione del quadrato e del cerchio con cui si apre il testo. L’equilibrio che ne deriva, proprio in quanto rinascita del corpo in questa esperienza di premorte, si esprime anche attraverso il contrasto e il relativo ricomporsi dei sensi predominanti della vista e dell’udito, che il gesto stesso della scrittura mette a sintesi e che ricorrono ora nella loro nuda valenza di organi naturali, occhio e orecchio, ora nella funzione dello sguardo e dell’ascolto, ora come “meravigliosa luce” e “grembo sonoro”, pozzo “claustrale” che “cattura quaggiù, nel suo piccolo cerchio finito, l’infinito” o dove risalgono le “voci di demoni solitari che abitano cavità acquatiche” di cui parlano “certe fiabe”. Soprattutto, ribaltandosi sul vissuto di chi scrive, lo stesso equilibrio diventa necessariamente equilibrio fra un passato che “lega ma orienta” e un futuro che è “distacco per andare verso, sempre più disorientati”: coordinate sulla mappa del tempo che si possono individuare solo volgendosi, con un movimento che richiama la torsione natale con cui la vita si dipana da dentro a fuori. La soluzione dell’equilibrio passa così nella sublimazione di un distacco vissuto come <perdita> e reinterpretato in un nome, il proprio, che si fa identità, forma come sintesi con l’“altra me stessa”: “Prendo quella parola, quel suono che mi somiglia e lo seppellisco sotto un albero, vicino alle radici”. Si tratta di un gesto ancora una volta <re-iniziatico> e ancora una volta ossimorico, che parte dal passato e propizia visioni, anche se non si sa più “se dal mondo che si è disfatto o da quello che arriverà”. Ma poco importa, perché ciò che si abbandona ora “è una ragione minuscola quanto un’orma di animale vista dall’alto di un monte” e la sensazione che resta al risveglio è quella di “una misteriosa, struggente bellezza. Nostalgia del grembo sonoro di mia madre o annuncio di un altro universo – illimitato – che mi viene incontro” come la meravigliosa luce di quel sole al tramonto che sembrava invece attesa. E non lo era. Forse era luce d’alba, quella che già si vede a Notte alta. “Qui anche la mia anima sembra ferma. Trattengo l’anima come il respiro. Dopo che se n’è volata via, questo respiro che cos’è?”
Melzo, fine giugno 2025
**
Lucetta Frisa, da Notte alta
La prima immagine che mi si presenta è un luogo chiuso da mura ma senza tetto, forse un chiostro: ci piove di striscio, da destra, un raggio di sole. Questo taglio obliquo della scena indica l’ora in cui mi trovo. È il tramonto, e la sua luce, densa del giorno trascorso, è sul punto di disfarsi.
Cosa nasconde quel luogo? Non so se ha la forma di rettangolo o di cerchio. Mi sembra rettangolare, l’occhio può riposare ai quattro angoli e non vorticare su se stesso, conosce già un ordine. È una geometria occulta che allude che allude a uno spazio sacro, mi separa dal mondo, crea esterno e interno. Questo luogo dove nulla manca, dove sono in pace, mi attrae irresistibilmente; avanzo e intorno a me la forma rettangolare si dissolve, e mi sento al centro di qualcosa di circolare. Non alzo gli occhi, non voglio null’altro; al centro può esserci un pozzo, nel pozzo acqua limpida o torbida, oppure nulla, un vuoto nero. Mi attrae come scovare una tana d’animale, qualcosa di palpitante che non si mostrerà mai.
So che sono qui perché mi sono umiliata, spogliata dii tutto, e mentre mi avvicino bisbiglio una preghiera. La mia voce non è voce imperiosa di cacciatrice ma richiamo seduttivo di chi chiede insieme assoluzione e amore. Io so che il mio occhio fissa quel punto, che la mia mente è lì, la mia anima è ricaduta lì; con pazienza imparo a congiungermi e morire nel mio oggetto d’amore.
Sono in questo assoluto non luogo che esiste in me prima di me, in una profondità dove mi attende, immobile, l’altra me stessa; ostile, inadeguata al mondo, sempre me l’ha sottratto.
Il mio sguardo verso il centro è calmo e dritto; vedo infine il mio desino e lo amo, amo il nulla e il démone che lo abita.
Guardo questo vuoto ma non vi precipito, lo tengo a distanza, insensibile, come chi cammina a piedi nudi su sassi e fiamme e non si ferisce né brucia. Guardo e resto serena. Scrivo guardando questo punto, comprendo quel nulla in me. Scrivo perché scrivendo posso simulare mille e una volta questo attimo che precede la morte.
*
Al centro del pozzo c’è qualcuno. Certe fiabe parlano di voci, démoni solitari che abitano cavità acquatiche; questo démone, una volta riconosciuto e addomesticato, conduce il viaggiatore dentro il pozzo; poi, improvvisamente, sparisce.
Raggiungere il destino è chiudere un cerchio, fare coincidere la propria esistenza con il suo invisibile progetto, cioè il ragno con la tela, il viaggiatore col viaggio. È punto di quiete e di estasi – che è fermezza di sguardo – inflessibile ma amoroso.
Non voglio indugiarvi troppo; solo quell’attimo è il senso, ciò che viene dopo è cronaca o maniera.
*
Mare, spiaggia e un orizzonte vuoto – il sole basso, al tramonto. Piedi nudi sulla spiaggia ancora tiepida, sabbia tra gli alluci e io che mi dico affréttati a riempirti gli occhi di tutta questa meravigliosa luce. È il sogno ricorrente del tramonto, fatto fin da piccola. Sempre il tramonto, mai l’alba.
Ora, mare e pioggia si sono concentrati in un unico punto, tutto quello spazio dilatato si è contratto in questa clausura, in questo cerchio stretto, e tornerà a dilatarsi per qualcun altro quando io non potrò più guardarlo.
La mente lo ha raggiunto: piano piano dovrà convincere il corpo a morire, perché al corpo, per morire, occorre molto pù tempo; la mente giunge al traguardo per prima e si mette in attesa. Giorno per giorno lo aspetta…
