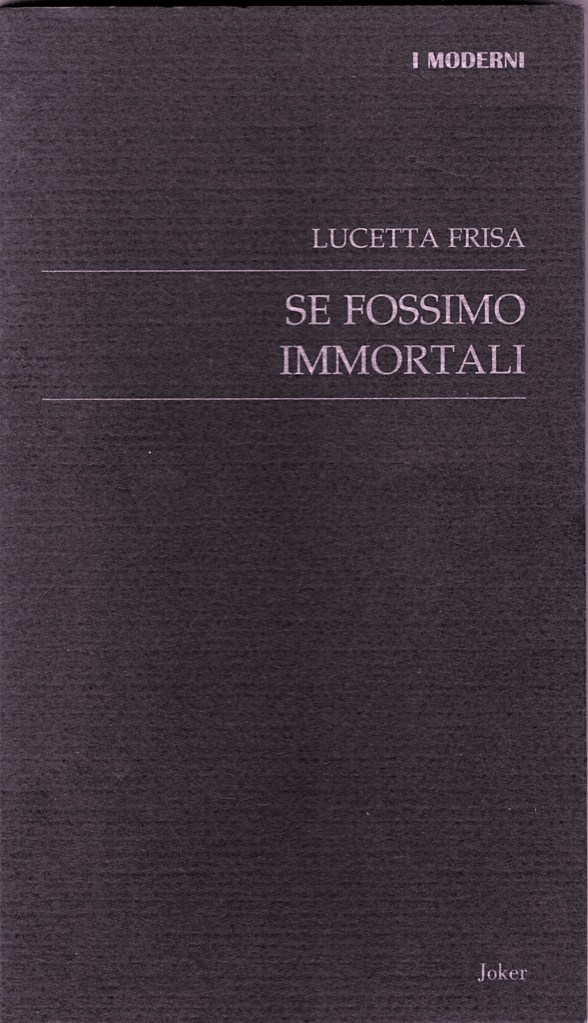
Individuazione e disvelamento in Lucetta Frisa
Merita più di una lettura, questa aspra raccolta di Lucetta Frisa (Se fossimo immortali, Joker, 2006); in essa sembrano infatti giungere a compimento le principali tematiche già ampiamente sviluppate nelle opere precedenti Notte alta (Book,1997) e L’altra (Manni,2001). Innanzitutto colpisce la complessa architettura che sostiene l’intero libro e che ora risulta funzionale a un percorso di individuazione svolto attraverso il flusso coscienziale di coppie di opposti, a iniziare da quella “interno/ esterno”, mirabilmente espressa con l’immagine del vaso (“Vaso etrusco”) nella poesia d’apertura e ripresa in limine alla sezione di chiusura Autoritratti diurni e notturni, significativamente trasposta nel suo attiguo femminile (“Sono seduta di fianco su un’urna etrusca”).
La dialettica interno/esterno, il contrasto fra involucro che contiene e protegge e insieme limita e soffoca, fra forma e acqua/contenuto, padre e madre, parola e significato, in sintesi: tra aspirazione all’infinito e perdita di sé e disarmata coscienza di una dimensione precaria di angoscia e insensatezza, di incompiutezza e dipendenza, si esprime fin da subito in una tensione che è insieme anelito e smarrimento di fronte ai grandi snodi della vita, e che non può essere colta se non come minaccia da cui proteggersi: “La paura – sull’autostrada un attimo ed è rogo –/ allunga la vita. Il disamore è concesso a chi invecchia” (da Il disamore),e “Non sopporta l’attesa e il desiderio:/ che cielo e mondo accelerino la corsa/ esplodano al contatto/ lo esaudiscano in fretta” (da Accelerazione). La compressione dell’energia che ne deriva diventa perciò spinta e controspinta, amore per lo spazio aperto e necessità di un ripiegamento che finisce inevitabilmente per essere percepito come intollerabile nella sua valenza claustrofobia: “Da spazi e suoni tanto sottili come si torna o non si torna più” (daIl sogno delle mosche); “Da qui non posso uscire /solo salutare chi passa/ ma il mio dolore rimane/ mentre sembrava andarsene” (da Persona). Nella trama di immagini sapientemente tessuta, si aprono fratture, crepe, scissure, minimi spazi vitali in cui anche la voce è maschera e “persona”, elemento naturale parimenti chiamato a passare attraverso la penitenza del nascere e dell’esprimersi sperimentando lo stesso contrasto, da interno ad esterno, e i rischi che entrambi comportano.
Nel percorso delineato, la raccolta giunge a un primo doloroso ma lucido approdo (Se fossimo immortali) dove i temi trattati, la dialettica vitale fra interno ed esterno e le sue molte declinazioni, si arricchiscono di nuove, composte riflessioni, che sembrano connotarne diversamente l’intenso tono emotivo: qui sono descritte stanze che si chiudono e si riempiono di vuoto, stanze rosse nascoste nel buio del cervello (le stanze di cinabro, della contemplazione estatica), i colori in cui entrano solo i mistici, appunto, insieme a maschere della follia di non morire, miniere e cavità, soffitti dove potremmo vedere dei e bambini volare e danzare; ma qui è anche il territorio manifesto del pianto, di un pianto senza oggetto, innocente, di un “pianto a mezzogiorno” quale dimensione naturale del destino umano, che favorisce l’irruzione di inattese sintonie (“eco che rincorre il suono come un atomo la materia”, “scia di pianeta suono di insetto”, “i polmoni spingono l’incomprensibile in gola e ci sei tu e il respiro”).
La tensione di prima sfocia così in una ferma presa di posizione: “l’idea dell’assoluto non mi piace/ è folle e crudele”, che apre magistralmente la sezione successiva (Come fanno i pazzi), dove “il vaso è spalancato” e la dialettica pervasiva di tutto il libro si traduce in sequenze rapide, di grande potenza espressiva: si parla di deserto, demoni, amore, freddo e caldo originari, terra, pianeti, assoluto amore, e ancora santi, morte, mondo, Dio, luoghi dove tutto è, appunto, estremo e smisurato, dove “non si accettano patti tra l’alto e il basso, il dritto e il rovescio”, e forte è l’esigenza di un minimo presidio, di un “porto franco”.
Nell’eponima sezione si assiste a una serie di trasposizioni che sembrano allontanare e depotenziare ma anche proteggere: dal presagio iniziale e delicato del pesce piccolissimo che “sulla spiaggia in silenzio ieri moriva”, all’acquario dove i pesci si susseguono in fugaci apparizioni che evidenziano continuità e somiglianze con il mondo di chi disincantato l’osserva. Qui, il porto franco è nella mediazione dell’immagine e del suono proposta dall’enorme tartaruga, “regina sorda e cieca di quel mare” (Acquario), nell’essere “esonerati dal pensare” (Porto franco), nel fondo marino che non ha orizzonte e dove luce e suono implodono in uno sguardo senza orbite […] che non vede perdita né conquista/, non vede questa calma supina/ nel porto franco sotto l’orizzonte”. In particolare il testo poematico di Porto franco si propone come una sorta di “ballata degli annegati” di chi sta in una dimensione fluida e intermedia tra vita e morte.
Così, “Adeguati al mare” (al Nulla o all’Infinito o all’Indifferenziato) i semimorti hanno compiuto il percorso verso l’individuazione, nessun senso è più cercato, sotto il sipario marino non si vedono né inferno né paradiso ma solo quello che già è scritto nel bios della nostra origine: e, da questa condizione limbale, sono pronti per essere “esplosi fuori dalla vita, espulsi con un atto di energia che cancella tutto”, con un atto innanzitutto di coraggio che riafferma, risolvendola così, la dialettica interno/esterno: ora si è pronti per “vedersi vivere da un’altra dimensione.”
Nella sezione finale, Lucetta Frisa lo fa in modo più diretto attraverso una serie di Autoritratti diurni e notturni, in un disvelamento quindi più intimamente individuale: autoritratti minimali, tracciati con pudore e delicatezza, ma anche con un’aspra lucidità che avvicina a tratti un’ironia struggente a un sarcasmo penetrante, ma mai greve: “[…] questo il sublime Quotidiano/ è commovente tornarci dopo una malattia/ le anime ronzano con i loro carrelli/il clima è impassibile questa luce/bianca bussa sei viva mi informa/- anche se solo così-e guarda/ “tutta questa bella roba da comprare è Vita/ nel giardino dell’Eden surgelato” (sesto autoritratto diurno); […] felice mi slaccio la gonna mostro l’intimo/non invecchio sdraiata in mezzo a Sky,/ imparo a vivere alla grande” (settimo autoritratto diurno). Le situazioni descritte, nel loro svolgersi di attualità quotidiana, diventano perciò molto concrete; eppure, nella cura di una mano che “rifa il letto lentamente”, lava i piatti alla sera, o nell’osservazione del sonno del compagno che le dorme accanto (“Tu dormi e non so rincorrerti”), in questo “esserci” accolto infine in tutta la sua duplicità esistenziale, la raccolta recupera una dimensione umanissima vissuta in funzione antiheideggeriana, che sembrava altrove preclusa: “Ti prego fammi credere di esserci /– senza lacrime lo dico –/ credere che tutto è vivo scorre si muove domanda non dà pace/ credere che anche le cose morte/ di notte si vestano di un corpo” (nono autoritratto notturno).
La tensione fra interno ed esterno diventa ora tensione fra notte e giorno, rapida sequenza in cui il conflitto della prima parte della raccolta si annuncia come depotenziato, quasi “abbassato” “nel clacson dell’ambulanza che insiste in orecchie irretite da un altro suono”, e ai toni più alti succedono quelli di un linguaggio quotidiano, quasi “basso”, dove emergono parole come “crema giorno e crema notte, trash, jeans” e ancora “gel, sky, bus, supermarket, formaggi Ying e Yang”. Il percorso drammatico verso l’autodefinizione di sé incede fra ombre e barlumi, rivelazioni e nascondimenti, resa e dissimulazione, in un succedersi di rispecchiamenti in cui l’autrice si sente padrona di un proprio regno e di una sua identità ora più reale, ma sempre vissuta dentro l’atto slontanante del “guardarsi” (“Mi vedo nascondermi […]”, “mi vedo camminare[…]”, “mi vedo uscire sul balcone”, “se scrivo è per trovare un angolo notturno”) che sfocia nei bellissimi versi che chiudono il terzo autoritrattonotturno, quasi un trompe l’oeil fatto di parole, giustamente ripresi da Mauro Ferrari nella sua postfazione: “Ma io non lo guardo mi vedo mentre non lo guardo guardandomi muovere i piedi”.
Il percorso tutto interiore dell’individuazione si compie così nella capacità di “non perdersi di vista” in questo gioco di apparizioni e dissolvenze in cui consiste la tecnica, o forse l’arte della ricerca (della perdita) della propria identità: una domanda che la poetessa ha lasciato in sospeso nel suo primo autoritratto con quella chiusa angosciata “Ditemi chi sono adesso”. È un’abilità appresa col tempo, affinata attraverso una costante riflessione, sorta di monologo interiore, che a tratti sfocia in una saggezza disinvolta e leggera, mai esibita, eppure così profonda: “si riaccende l’antico automatismo del sogno che sogna”, “so che le cose celesti si comportano come quelle terrestri” (settimo autoritratto notturno) anticipando quella “saggezza naturale”, viatico o occasione dell’ultima “falsa fuga da sé” con cui il libro si chiude.
Un libro impegnativo e intenso, anche per le scelte stilistiche di un linguaggio a tratti dissolto, percorso da un sommovimento interiore (terremoti, maremoti e scosse telluriche pure proposti in alcuni passaggi della raccolta), da un ritmo sempre incalzante e modulato, una delle caratteristiche strutturali più rilevanti della poesia di Frisa – ora attraversato da un’imminenza che impedisce la perfezione: “Chi se ne infischia delle regole”,oppure: “L’aria non ha cassetti:/ e una scarpa è lì e un occhiale è là/ biancheggiano foglie e camicie/ in aria come bandiere” (nono autoritratto diurno), tuttavia sostenuto da una severa sobrietà, da un’angoscia mai sopita, presagio di crolli prossimi, che al linguaggio stesso inibiscono aspirazioni e fasti, spesso appena accennati. Nel quotidiano introspettivo c’è un respiro metafisico e in questo respiro metafisico l’intromissione del quotidiano: questo, a mio giudizio, è forse l’aspetto più originale e convincente della poesia di Frisa e, in particolare, di Se fossimo immortali.
Melzo, 25 febbraio 2007
