
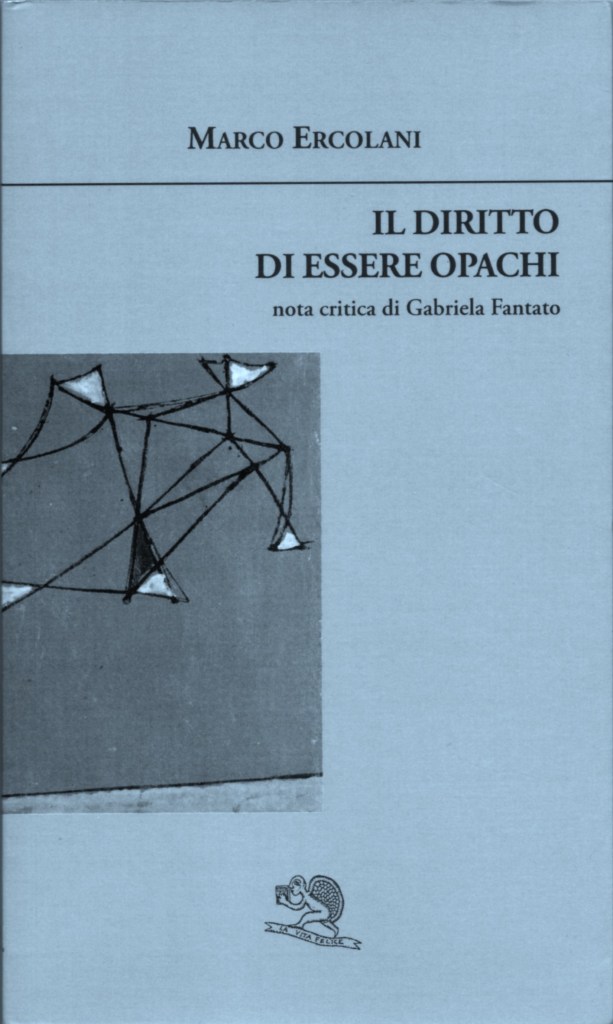
Una verità più vera
Tra Michaux, Duchamp, Borges (e un po’ di Canetti) si inserisce una tua particolare cifra che denota, oltre la fantastica acquisizione del testo come oggetto energeticamente esistente al di là, o al di qua, di ogni (non)necessaria testimonianza, una intensa proposta di analisi e conoscenza. Voglio dire che, dimostrandosi gli apocrifi introvabili per loro stessa natura, ma veri in quanto storicamente collocati nel tempo e nella vita di personaggi realmente esistiti, il piacere della loro invenzione si pone come proposta critica di acutissima rivelazione. Così si rivivono opere e giorni di grandi fantasmi, cogliendone (secondo la valenza di ogni pregnante operazione critica) una verità da vivere più vera della vita assoluta (Gio Ferri, “Lettera inedita”, 8/5/1995).
**
Il labirinto
In una biblioteca pubblica giapponese viene trovato un grande foglio arrotolato dimenticato lì da parecchio tempo. Contiene il disegno di un immenso labirinto. Sembra la mappa di un cervello ciclopico o di una megalopoli. Si viene a sapere (è il figlio del suo autore a informarci) che il padre, custode della biblioteca, ha impiegato 7 anni per eseguirlo; ovviamente la soluzione o il centro non esistono perché le sue linee si ripiegano in sé stesse in snodi come di autostrade e proseguono il loro tracciato ad libitum, cioè fino al bordo del foglio. Il formato del foglio (A 1) ha accidentalmente impedito il proseguimento del disegno fuori dal disegno… Oppure l’autore, più semplicemente, ha interrotto per noia, malattia o morte, dato che poteva procurarsi un altro foglio e continuare su quello la sua opera di “interminabilità”. Solo il formato del foglio fisico gli ha imposto necessariamente un Alt, come il limite naturale della vita umana impone un alt a tutti i mortali. L’ossessione di questo disegno assomiglia a quella dello scrittore-psichiatra Marco Ercolani che per tutta la vita ha scritto ininterrottamente e altrettanto ininterrottamente è stato a contatto col cervello umano, con la psiche dei suoi pazienti folli: (a proposito dove si nasconde la psiche nel cervello umano? è il viaggiatore dentro al suo labirinto che può impazzire non ritrovando il modo per uscirne se non con la morte fisica?). ”Io abito il mio cervello / come un tranquillo possidente le sue terre// Il mio cervello abita in me / come un tranquillo possidente le sue terre” – scrive Valerio Magrelli nel celebre incipit del suo primo libro.
Ercolani sa dominare il suo caotico labirinto, sa tesserne il filo, controllarne le imprevedibili svolte, gli incontri, i probabili intoppi. E i grovigli. La sua opera di totale e ininterrotta scrittura è simile al dna della vita, alla sua spirale che si carica di volta in volta di complessità sempre più complesse e che, disegnata su foglio, riflette un labirinto senza principio né fine: la metafora più semplice che ci ispira è quella della mappa genetica dell’umanità di cui noi, singolarmente, facciamo tutti parte. Il centro non c’è, esiste solo “la magnifica ossessione” di chi vuole arrivarci (la missione di Teseo era quella di uccidere il mostro, cioè il vuoto assoluto, pronto a divorarlo), pur sapendo che il suo viaggio è troppo lontano dalla meta e, anzi, la meta stessa non esiste se non nel proprio sogno, non esiste l’acme del viaggio, punto assoluto in cui convergere per sprofondare in alto o in basso (a seconda delle nostre immaginazioni religiose). Il centro, in quanto inizio e fine è l’illusione del tempo mortale affidato alla singola creatura, è il nostro ripiegarci “a specchio” e dietro lo specchio c’è solo chi mette fine al nostro viaggio insieme all’opera. Dunque, solo la morte fisica impedirà a Ercolani di continuare la sua scrittura che, prima di lui e con la stessa tenacia, hanno perseguito forse Fernando Pessoa e Thomas Bernhard (con gli artisti visivi il discorso è diverso, a cominciare da Antoni Gaudì la cui Sagrada Familia è già un progetto incompiuto e interminabile). Tutti artisti vissuti grazie e per la loro scrittura e il loro segno, vissuti per inseguire se stessi e l’incedere irreversibile della propria vita attraverso l’arte con opere che si arrestano solo quando i loro autori concludono il loro viaggio terreno. Scrive un giovanissimo Ercolani: “Vorrei edificare uno stupendo labirinto in cui le parole e la vita si fondessero in un incendio possibile…”: coerenza ossessiva di un percorso fin troppo lucido di scrittore. L’estrema tenacia di perseguire questo progetto non è espressione di onnipotenza, ma una sorta d’imperativo etico che impone l’esibizione della nostra finitezza umana indissolubilmente legata all’opera che lasceremo dopo di noi, finitezza che si nientificherà o si mescolerà all’infinito con tutte le altre opere interrotte. L’idea appartiene a chi, romanticamente, identifica la propria scrittura con la vita stessa. Se la nostra vita è imperfetta (“l’imperfezione è la cima” scrive Yves Bonnefoy), nell’opera si intensificherà il tentativo di esserlo meno. Ma dopo, se l’opera “lasciata sola” (Cesare Viviani) vivrà ancora di vita propria, non dipenderà più da noi: forse nel labirinto del web sarà possibile, dopo la fine del proprio tempo mortale, che sia raggiunta da un lettore, curioso e casuale (Lucetta Frisa, 2 febbraio 2012).
**
Un caos ordinato
Marco carissimo, ho letto Turno di guardia tutto d’un fiato. Non poteva essere altrimenti, la tua scrittura è appassionante, limpida, addirittura gratificante per chi la legge, lo sai, inutile ripetere quel che ti ho sempre detto. Inoltre mi è piaciuto perché, più di un diario medico diciamo, o di osservazione e contenitore di malattie mentali, mi sembra che tu intenda teorizzare il rapporto follia-scrittura e adoperi il tuo posto di guardia come mezzo per esprimere concetti tuoi che avresti comunque. Una riprova, intendo. Non so se sia nel giusto, ma essendo appena tornata dal San Raffaele, centro di ricerca dove sono messi insieme ai pazienti normali (come me) con recupero cioè veloce e transitorio, operati semplici insomma, malati anche mentali, non solo parkinsoniani, alzheimer o come si scrive, ma folli, alcuni penserei irrecuperabili, che però loro studiano. Ecco, ho notato che quel tipo di follia non aveva mai un’espressione lunga né corretta grammaticalmente. Erano spezzature, urli, frenesie inarticolate, poi anche parole di verità, certo (ho preso appunti perché sono stata insieme a due di questi in camera), ma rapide, suggestive e spaventate nel concludersi in un discorso. Forse si tratta di luoghi diversi con persone diverse, ma ho l’idea –e se ciò fosse vero non toglierebbe niente alla bellezza dei tuoi racconti romanzo- che il tuo libro sia un trattato sull’origine di certa poesia, le immagini sembrano più tue che loro, nel senso che sono compiute, troppo corrette. Che insomma sia tu a calarti egregiamente nella follia la cui voce è assolutamente più di corpo, di straniamento fisico e raramente esprime concetti; nella mia piccola e veloce esperienza, ho intuito forza di straordinaria verità in quei lamenti o invettive, li ho interpretati, certo non ha fatto loro scuola di scrittura, ma quelli (che pure non erano in un ospedale psichiatrico e si suppone fossero recuperabili, visto che si trovavano lì), non credo sarebbero diventati degli allievi o che avrebbero raggiunto comunque o in qualche modo una logica discorsiva. Forse così saranno i pazienti che vanno nello studio di uno psichiatra e poi magari lavorano, vivono anche fuori. Non so se mi spiego bene. Ora questo è ovviamente un mio parere (e forse penso troppo a certe malattie mentali di Viaggio al termine della notte) dico non toglie nulla alla bellezza teorica di quel che ne vien fuori. Anzi, lo riterrei se fosse questo il tuo intento, un modo nuovo e diverso di esprimere l’humus di un tipo di scrittura. Pur appartenendo io alla schiera di chi crede che solo la salute, una certa collocazione del soggetto all’interno del “modulo salute mentale” riesca a ordinare il caos in una poesia o in un volume. Quando insomma la follia non è patologia estrema, tanto più che il motore creativo, di per sé, quando si mette in moto, ti respinge indietro o avanti e ti fa perdere o superare la barriera di una salute tout-court, che è piatta e inutile visione del mondo….Leggere queste pagine è stato come leggere un altro tuo sogno nel buio della realtà, una tua ennesima sparizione da te stesso per ricrearti da qualche altra parte, in un altro modo. E sempre da par tuo (Lettera di Cristina Annino, 2012, per “Turno di guardia”).
**
Aura
La poesia è per Ercolani il punto cieco di una ricerca in bilico fra la “vertigine” dello scavo e la “misura” (per citare il titolo di una sua opera critica) del garbo razionale. E’ il cono d’ombra che custodisce il sole: forse per questo il buio, nelle sue varianti semantiche (opacità, invisibilità, cecità, ombra), è presente ovunque. Scrive l’autore: « la poesia non è soltanto la struttura formale di un testo poetico, ma quella zona imprevista e anomala del “percepire” la parola, dove la sillaba rigorosa e la vertigine dell’immagine si incontrano (…) per trasfigurare (sfigurare) ogni precedente pensiero e conoscenza del mondo». Un “sogno in presenza della ragione”, dunque: mai la citazione di Tommaso Ceva – amata da Montale, abusata da molti e riportata da Ercolani al suo esatto rigore culturale – sarebbe più appropriata. Come negli antichi greci, che non avevano ancora separato la forza del logos dalla profondità del mistero, la poesia per Ercolani è una preparazione a quella morte che “disimpariamo”; un’educazione dello sguardo a vedere senza essere visti… La scrittura presenta poi l’ulteriore effetto paradossale di ricavare dal buio la luce, dal picco dell’onda la visione di un’isola. Dalle “materie scomparse”, dalla stessa corporeità in disfacimento, la poesia trae senso e verità. Vita e morte, forma e materia si scambiano le parti: tutto nasce dalla morte. Scrivere diviene un modo di rapportarsi ai trapassati, di sentirne la presenza pur nel silenzio.
Il mondo è fenomeno, ma in senso schopenhaueriano: maschera ed evanescenza. Il sonno nella scrittura di Ercolani diviene allora viaggio astrale verso un noumeno forse non troppo irreale. Sonno e sogno sono ciò che Maria Zambrano ha chiamato“forma sogno”: uno strumento privilegiato per trascendere se stessi in una direzione che non è quella dell’obnubilamento, ma piuttosto del risveglio, del non “accontentarsi d’essere creatura”. Se confrontiamo i versi di Ercolani con la narrazione contenuta in Taala, un suo enigmatico libro uscito alcuni anni fa, il cerchio si chiude. Taala è il sogno collettivo di una città di cui nessuno può più dire se sia incubo, utopia o realtà: anche lo psichiatra, incaricato di prendersi cura dei folli e alter ego dell’autore, viene infine inglobato nel sogno. Non si sa chi va e chi resta, direbbe ancora Montale. La poesia di Ercolani non si limita a descrivere l“infinita vanità del tutto” ma in qualche modo performa il pensiero di cui è sostanziata: i suoi versi, intrinsecamente poematici, sfilano sotto gli occhi del lettore come se fossero scritti con l’inchiostro simpatico. Pur dotati di una potenza che colpisce, non sono semplici da ricordare uno per uno – come a volte accade, all’opposto, con certi versi di troppo facile presa immaginifica – ma soltanto nell’insieme e per così dire nella loro aura. Nell’incarnare il dissolvimento, nel continuo e quasi caleidoscopico scambio di segno fra buio e luce, questa scrittura insegna che la morte non è l’opposto della vita, ma il suo perenne serbatoio: la sua riserva di senso e di forma (Alessandra Paganardi, 2010).
**
Daimonia
Leggendo Ercolani io non conosco nessun Ercolani, in realtà, ma un flusso di scritture altrui, una smisurata, parassitaria emorragia della parola alle prese con un doppio mistero. Quello, abissale, dell’identità, con tutti i suoi rispecchiamenti più o meno perturbanti e tutta la sua brava coorte di falsembianti in veste di ego scriptor; e quello, ancora più abissale, della non-identità connesso all’esperienza del soverchiante – mistero, questo secondo, che il pseudo-longiniano Ercolani insegue collocando ogni volta di nuovo il suo instancabile scandaglio mediatore nell’invisibile crocevia in cui si incontrano, per separarsi, la daimonia “alta” dello spirito creatore e quella “bassa” dello spirito alienato (Massimo Morasso, 2010).
