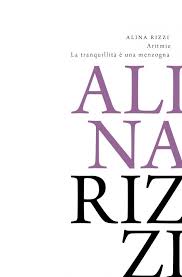Disegno il perimetro quadrato
del giardino che rinasce
tra siepi scomposte
fiori spontanei
l’erba tenera di marzo.
Misuro i passi nel sole
uno dietro l’altro
quel tesoro inaspettato
che ora sembra invidiabile
dalle finestre più alte.
Non hanno notato
che misuravo già da anni
in tempi non sospetti
il recinto rigoglioso
scavando buche con le unghie.
**
Non verranno a suonare
neppure oggi
neppure domani
preferendo non rischiare.
Ligie al dovere cercano il danno
che sospettano ovunque
anche nel sole e nel vento
in cui le attendo impietrita.
Ma lasciarsi catturare
è ancora un disonore
non cedo non lo accetto
combatto sola e ammutolita
per quel diritto negato
mascherato e furbo
che non sento letale
quanto il deserto dilagante.
**
Ho lavorato anni per un abbraccio
che apparisse spontaneo
anche da parte tua
ed è bastato un comunicato stampa
di un sabato alle diciotto
per dividerci senza appello –
ora puoi mascherare col rispetto
quella prudenza ossequiosa
che non ho mai condiviso
ma che rispetto
non più umiliante
appena accenni il gesto
di ritrarti a testa bassa.
**

Quanto tempo regalato
per osservare le ombre
dietro gli occhi chiusi
per ascoltate il vento
nel sole di aprile
e respirare sdraiata
traboccante di niente –
non fosse per le sirene
che si conficcano d’un tratto
aghi nel petto
trascinando al buio
il tempo di un altro.
**
Resisto alle parole
un canto di sirene
per non scoprirmi
in difetto di vita
per non perdermi
i fatti salienti
quelli che dimentico
vergognandomi
appena riapro il quaderno.
**
Un distanziamento di anni
una piccola morte
ricordando il piacere infinito
all’infinito – regolarmente –
coltivando l’attesa
in un rito scaramantico
quel profilo dietro gli occhi
chiusi – nel respiro sospeso.
**
Benedetto il virus della distanza
che ha giustificato il ritorno
a piedi scalzi e la
pelle sdrucita
adducendo pretesti –
la vita che si sfila dalle dita –
ormai superflui.
Benendetto il virus della pazienza
che falcia a migliaia
ma ci ha trovati ancora eretti
più deboli e persi
più tristi e nervosi
ma senza volti da piangere
oltre i nostri rigati dal tempo
sotto il blu della maschera.
**
Un anno dopo esatto
torna il rosso separazione
ferita ancora fresca
che spurga nuovo sangue.
Vita che si dibatte
che si assembra rabbiosa
per sopravvivere un’altra primavera
e non sentire
non sentire
altre sirene ordini prescrizioni
state a casa! – col megafono
alle due del pomeriggio
paralizzati nel sole
immobili sotto gli alberi
che fioriscono di bianco
a dire basta
a dire resisteremo
ma senza crederci davvero
perché la terza volta
non ci si riesce più
si lascia andare
si annuisce al cielo terso.
***

L’autrice, come attraverso le pagine di un diario interiore, guarda il suo dolore – a cui non è necessario dare un nome preciso – senza ritrarre lo sguardo, con sconsolata e spesso sarcastica amarezza. E se “A volte scrivere / è una maledizione” è proprio l’atto di scrivere (o solo di leggere libri) a mitigare le delusioni, a raccogliere la sfida del vivere, a dare un senso anche provvisorio alle pene sofferte: «…I libri / più del pane quotidiano / desiderava e non venivano / incistati tra la carne e i nervi». Un’osservazione, obliqua ma utile: il tono del libro è musicalmente una mezza voce, un parlato mai troppo lirico, una prosa intonata che non corteggia una lingua sperimentale e si sottrae a strategie linguistiche sofisticate o versificazioni erudite («Meritare l’oblìo / quieto e arreso / senza spigoli acuti / dove lasciarsi accadere»): si limita a trattare con sprezzatura e fermezza la materia ovvia e brutale della sofferenza esistenziale, il “lavorìo incessante della sopravvivenza”. Nel suo trattato di poetica e di retorica, Del sublime (“Perì Ipsous”), Longino parla della “adeguatezza” del mezzo espressivo come della forma necessaria di persuasione del discorso. Alina Rizzi, nella sua poesia minima e sgomenta, brusca e senza appigli, resistente e spezzata («Poi le mani, le lettere interminabili, i libri migranti») trova questa “adeguatezza” nel tono della sua voce, nell’esercizio lucido di una scrittura breve. (M.E.)